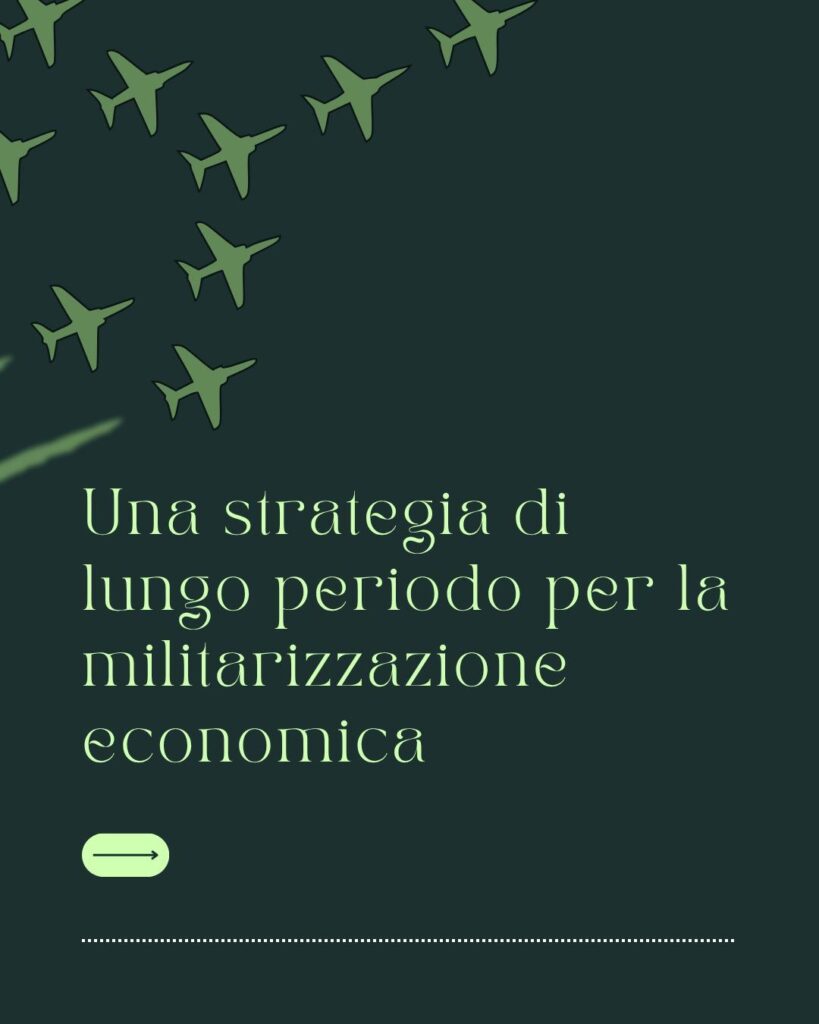Una strategia di lungo periodo per la militarizzazione economica
Da pochi giorni il Ministero della Difesa ha pubblicato il Documento Programmatico Pluriennale della Difesa 2025-2027. Si tratta in soldoni dell’aspetto programmatico del comparto bellico italiano. La propaganda del Ministero definisce la Difesa come “volano per innovazione e sviluppo”.
Dietro il linguaggio tecnico, si nasconde un piano di espansione strutturale dell’apparato militare: il Ministero si presenta come “motore industriale” del Paese, giustificando l’aumento delle spese con ricadute su occupazione e tecnologia.
L’Italia ha aderito alla nuova linea NATO, che prevede di raggiungere per tutti gli Stati membri il 5% delle spese militari così spartito: 3,5% del PIL in spese militari propriamente dette e all’1,5% per la sicurezza o le infrastrutture (vedasi Ponte sullo Stretto, che collegherebbe il confine sud della NATO – la Sicilia, il Muos etc – con il continente).
Un livello di spesa potenzialmente superiore a quello del periodo della Guerra Fredda.
La Legge di Bilancio 2025-2027 prevede 35,094 miliardi di euro in 15 anni per:
- 22,5 miliardi dal Fondo investimenti della Difesa;
- 12,6 miliardi dal Ministero delle Imprese (MIMIT).
Gli investimenti coprono ogni settore:
- Terrestre: nuovi mezzi corazzati, artiglieria, droni armati.
- Aereo: caccia di sesta generazione, sistemi missilistici, capacità “Extended Strike”.
- Navale: navi d’attacco, sommergibili, droni subacquei.
- Cyber e spazio: intelligence digitale, satelliti militari, “Space Domain Awareness”.
Di più. L’Italia con la Legge di Bilancio 2025 stanzia 50milioni per la ristrutturazione di tre stabilimenti militari situati a Baiano di Spoleto, Fontana Liri e Capua, gestiti direttamente dall’Agenzia Industrie Difesa. L’obiettivo è aumentare la produzione di componenti critici come la nitroglicerina e la nitrocellulosa, necessari per munizioni di medio calibro, riducendo così la dipendenza dalle forniture estere e rafforzando l’autonomia produttiva nazionale.
Ancora più forte appare la saldatura tra Università e Guerra con il Piano Nazionale della Ricerca Militare – PNRM.
La guerra futura, che intreccia militare, civile ed economia, è in realtà la guerra odierna. L’Italia è attualmente impegnata in 43 missioni militari (nel solo anno 2025), con più di 12mila soldati utilizzati. La guerra odierna è anche – e forse soprattutto – guerra interna. Come diceva Simone Weil: “Il grande errore in cui cadono quasi tutte le analisi riguardanti la guerra […] è di considerare la guerra come un episodio di politica estera, mentre è prima di tutto un fatto di politica interna, e il più atroce di tutti.”
Una parte cruciale del DPP è dedicata alla cosiddetta “funzione sicurezza del territorio”, che affida ai Carabinieri un ruolo centrale nel processo di militarizzazione interna. Soldi per nuove assunzioni, soldi per ammodernamento delle caserme, soldi per nuove armi.
Tra le misure previste:
- Acquisizione di elicotteri, droni e veicoli tattici con uso duale (militare e civile).
- Sistemi di sorveglianza digitale e cyber-investigazione (deep web, criptovalute, digital forensics).
- Estensione dell’uso del taser e di armi “non letali” a livelli ordinativi sempre più bassi.
- Ruolo crescente nello “Stability Policing”: attività di controllo sociale e gestione di crisi anche in territorio nazionale.
Questo spostamento funzionale rafforza il ruolo dei Carabinieri come parte integrante della difesa militare, abbattendo ulteriormente il confine tra sicurezza civile e logica bellica.
La militarizzazione non si limita più al piano geopolitico, ma penetra nelle città, nei sistemi informativi e nella gestione dell’ordine pubblico, preparando la società a un modello di sicurezza permanente in tempi di guerra totale.